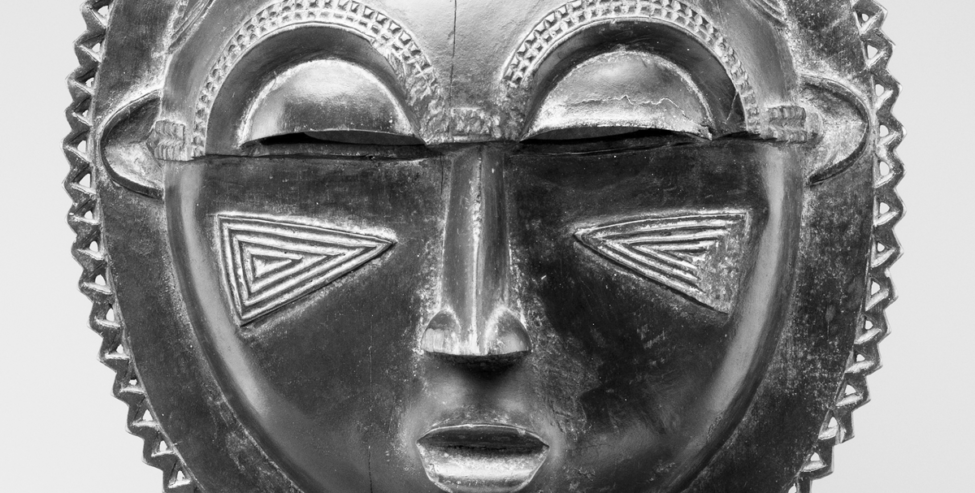
Home / Blog / Edu / 10 Dicembre 2020La scuola del futuro, tra teoria e pratica
Ogni anno Eduscopio, progetto di di Fondazione Agnelli nato nel 2014, stila una classifica dei migliori istituti superiori italiani per fornire ai ragazzi e alle loro famiglie alcuni indicatori per identificare il percorso di studio che meglio può rispondere alle loro aspettative. Il confronto tra istituti avviene partendo dai risultati ottenuti dagli studenti nei due anni successivi al diploma, sia nella formazione successiva che nell’avvio della vita lavorativa.
Per ogni tipologia di scuola vengono presi in considerazione fattori diversi: per i licei generalmente vengono analizzati i risultati universitari (voti e crediti ottenuti) e il numero di esami conseguiti, mentre per gli istituti tecnici e professionali i dati interessanti riguardano il successo dell’entrata nel mondo del lavoro, in base alla coerenza tra percorso di studi e ambito di occupazione, ma anche la durata dei contratti ottenuti. Questa differenza nasce dal fatto che ogni indirizzo di studio presenta un’offerta formativa e obiettivi specifici.
La finalità di Eduscopio non è quello di creare una graduatoria e una competizione tra gli istituti italiani, quanto piuttosto aiutare i ragazzi in uscita dalla scuola media nell’orientamento, per trovare il percorso che più valorizzi le loro capacità e meglio incontri le loro aspettative formative. Allo stesso tempo le scuole sono stimolate a consolidare il loro metodo e la loro offerta alla luce dei risultati di queste analisi comparative.
Ad influire sui risultati degli studenti post diploma, lavorativi ed universitari, incide anche il grado di innovazione e di sperimentazione di nuove iniziative all’interno delle scuole. In un contesto di profondo e veloce cambiamento sociale, l’istruzione deve fornire agli studenti i mezzi per capire e rispondere alle necessità che si vengono a creare, stimolando lo sviluppo di competenze trasversali e delle soft skills.
Sperimentazione e innovazione nella didattica
Tra le attività utili ad implementare la proposta formativa, sono arrivate ormai alla sesta edizione le Olimpiadi di Robotica: una competizione gratuita che si ripete annualmente, dedicata agli studenti di istituti secondari superiori e promossa dalla Scuola di Robotica di Genova in collaborazione con il MIUR.
Scuola di Robotica è un’associazione no-profit nata nel 2000, certificata come ente formatore dal Ministero dell’istruzione, il cui obiettivo è la promozione di attività laboratoriali di formazione, educazione e divulgazione nell’ambito della robotica e delle materie STEM; per l’anno scolastico 2020/21, il tema della competizione è l’ambiente. I partecipanti dovranno quindi presentare un prototipo funzionante da far muovere in acqua, sulla terraferma o in atmosfera con l’obiettivo finale di proporre soluzioni per un miglioramento delle condizioni ambientali e della qualità di vita dell’uomo.
Gli studenti che si sfideranno dovranno collaborare durante la costruzione meccanica, ma sono anche spinti alla formulazione di nuove idee tenendo presente le criticità del presente, in particolare la crisi climatica che stiamo attraversando; questa progettualità avvia un in loro un percorso che stimola la competizione e l’apprendimento pratico, permettendo ai ragazzi di vedere un’applicazione pratica di quello appreso a scuola, accrescendo la loro curiosità e il senso di appagamento.
Una grande attenzione in questo genere di sperimentazioni è quindi sullo sviluppo di competenze trasversali; in questo senso si rivela interessante il Service Learning, approccio pedagogico che prevede la realizzazione di progetti (a volte pensati dagli stessi alunni) che nascono in risposta a situazioni di vita reale e bisogni di un determinato territorio, e coinvolgono gli studenti in maniera attiva.
Gli ragazzi seguono le diverse fasi di questi programmi, dall’individuazione di un obiettivo, la progettazione e realizzazione dell’attività, fino alla valutazione degli esiti finali che comprendo delle riflessioni sui contenuti appresi nel corso dell’esperienza stessa. Le competenze che vengono sviluppate non sono strettamente ricollegabili ad una particolare disciplina, ma sono legate ad una modalità di apprendere e operare a stretto contatto con il tessuto sociale circostante.
Queste proposte inserite nel curriculum didattico, hanno anche la capacità di rafforzare il legame tra lo studente e il territorio che abita, che si trasforma agli occhi dei ragazzi in un nuovo spazio di laboratorio, aprendo percorsi di cittadinanza attiva e di responsabilizzazione dei ragazzi.
Service Learning in Italia
In Italia uno dei primissimi progetti di Service Learning realizzato è quello del Liceo Attilio Bertolucci di Parma “WELab & WEMAP: un’azione di service learning ambientale”, che in collaborazione con l’Università di Parma, la start up WeLab e il FabLab di Parma ha deciso di coinvolgere gli studenti nell’analisi delle acque di fiumi e torrenti della provincia. L’esperienza è stata possibile grazie ad un laboratorio digitale di analisi messo a disposizione della scuola da WeLab, sviluppando quindi anche le loro competenze digitali degli alunni, che è poi rimasto a disposizione degli studenti all’interno delle 35 scuole che hanno aderito al progetto.
Un’altra iniziativa interessante, che tocca temi differenti, è quella proposta dall’Istituto comprensivo “Amerigo Vespucci” di Vibo Marina “I migranti non sono un pericolo, ma sono in pericolo”. Il flusso migratorio che interessa la città è continuo, e quindi entrato nella vita quotidiana della comunità; partendo da questa consapevolezza all’interno della scuola sono stati accolti una ventina di minori, sbarcati in Italia -senza accompagnatori- nel 2017, e seguiti in percorsi laboratoriali dove hanno raccontato le proprie storie con l’uso di diversi mezzi: fotografia, video, disegni. L’obiettivo di questi laboratori è stato quello di ridurre il senso di isolamento e spaesamento dovuto all’inserimento non mediato all’interno di una cultura differente; le diverse attività hanno favorito l’integrazione e l’apprendimento della lingua italiana.
Ma a beneficiare da questo progetto sono stati anche gli studenti, che si sono confrontati tra pari vista l’età degli altri ragazzi, ma con esperienze di vita molto diverse dalle loro, in un luogo di reciproco scambio e condivisione, influendo sullo sviluppo di una cittadinanza globale che rispetta le differenze. Questo particolare progetto, oltre ad essere stato coordinato dagli insegnanti, ha richiesto la partecipazione di servizi sociali che hanno prima conosciuto i migranti coinvolti, raccogliendo informazioni riguardo alle loro conoscenze linguistiche e i bisogni educativi; hanno poi fornito agli studenti le conoscenze e i mezzi per affrontare questo percorso in modo più consapevole ed efficace.
A Rovereto, gli studenti dell’indirizzo sociale e turistico dell’ Istituto Don Milani hanno realizzato il progetto “Handycamp”, un soggiorno estivo della durata di due settimane dove si sono presi cura di persone con disabilità, ospitandole in strutture residenziali locali. Gli studenti, investiti della responsabilità di gestori di una struttura sociale, sono stati incaricati di occuparsi sia della parte amministrativa che dell’animazione, grazie anche alle lezioni frontali precedentemente tenute; per tutta la durata del progetto sono comunque stati accompagnati dai loro professori. Gli studi di indirizzo sono stati messi in pratica in questa iniziativa, testando la formazione degli studenti sul campo e fornendo allo stesso tempo un servizio alla comunità
Queste attività sono esempi meritevoli, ma non i soli, realizzati all’interno delle scuole italiane, con l’elemento comune data all’importanza dell’insegnamento situato in un contesto con determinate specificità ed esigenze, e sempre orientato anche all’acquisizione di competenze: il Service Learning non si pone infatti come approccio sostitutivo ma integrativo alla didattica tradizionale, combinando processi di apprendimento e di crescita individuale.
L’obiettivo di queste azioni è, come detto, quello di innovare la scuola integrando e arricchendo i percorsi formativi, preparando gli studenti a muoversi e ad agire più consapevolmente all’interno della società in continuo cambiamento e a sfruttare le nuove opportunità che si presentano. Una scuola che cambia, in meglio.
